La figura dello storico dell’arte e il restauro
di Cecilia Frosinini
Storica dell’arte
Opificio delle Pietre Dure
Da: Kermess n. 100, Ottobre – Dicembre 2015
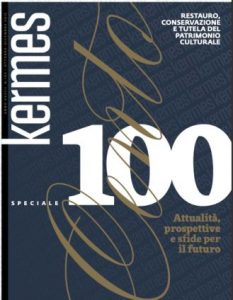
Il restauro si è sempre connotato come materia principalmente legata alla storia dell’arte e a una percezione di tipo umanistico dell’oggetto artistico, visto come portatore di messaggio estetico e di contenuti storici, prima che nella sua materialità e nei suoi processi di degrado. Si è restaurato per leggere, per restituire all’apprezzamento, per assicurare la trasmissione di un contenuto e di un valore riconosciuto e apprezzato esteticamente e storicamente. Non a caso, infatti, i grandi nomi legati al restauro sono stati tutti. lino all’avvento della visione scientifica della disciplina, artisti, prima, e storici dell’arte, poi. Ad essi dobbiamo la teorizzazione della disciplina, la concezione che un metodo fosse necessario, una lettura filologica imprescindibile, in una visione degli oggetti artistici come elementi di una lingua 0 frammenti di un sistema anatomico, complesso ma unitario, come un corpo. Da questa impostazione, radicatasi soprattutto in ambito italiano, nascono anche le grandi consonanze tra storici dell’arte e restauratori, che spesso, almeno in passato, condividevano una formazione umanisticamente orientata, storica e volta alla contestualizzazione i primi, di tipo artistico i secondi.
Nell’aprirsi del campo del restauro alle varie possibili componenti scientifiche, dagli inizi del XX secolo in poi. il dialogo fra storici dell’arte e restauratori si è andato arricchendo di un terzo interlocutore, l’esperto scientifico -chimico, fisico, biologo, geologo o, più modernamente, la nuova figura del conservation scientist, cioè un esperto di applicazioni di diagnostica artistica. Queste tre figure, diverse ma complementari, hanno costituito, nei casi migliori, quello che George Leslie Stout (1897-1978). nel fervido e pioneristico mondo dello Straus Center for Conservation and Technical Studies di Boston, negli anni Venti, definì “the three-leggedstool” (cioè ‘lo sgabello a tre gambe’), chiamate a operare nel campo del restauro, in un equilibrio che non concedeva preminenza alcuna a nessuna delle tre componenti. La collaborazione e il dialogo, nei decenni, sono spesso rimasti un auspicio, più che un metodo ineludibile, il solo che avrebbe consentito non solo il corretto metodo scientifico di conservazione, ma anche l’avanzamento conoscitivo nei confronti di ciascuna opera d’arte.
Ove questa interazione si è realizzata (ed è quasi pleonastico dirlo, il più delle volte legala a felici incontri personali, perché nessuna legge statutaria può imporre un metodo in cui non si crede) è stata la capacità di dialogo fra storia, tecnica e scienza, è stato l’aver trovato una lingua comune, a far uscire il restauro dalla routinaria manutenzione “di galleria” o dal mondo artigianale, per farlo assurgere a vera disciplina e, in un certo senso, a primaria disciplina dello scambio intellettuale. E ad aver creato un tipo di visione dell’opera d’arte in continua evoluzione, a seconda della comprensione dei processi di modificazione cui i materiali stessi di cui è costituita la sottopongono. Questo tipo di lettura e di studio ha faticalo non poco a farsi riconoscere come disciplina e non come mero tecnicismo o esercizio di una funzione amministrativa, soprattutto perché sentilo come antagonistico di una imperante connoisseurship che per lungo tempo è stata dominante ed esclusivista nel campo della storia dell’arte. Al giorno d’oggi, dopo più di 40 anni dalla fondazione del Ministero per i Beni Culturali come entità amministrativa autonoma, è evidente che molteplici siano le finalità che discendono dal principio di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, ma fra esse ancora stenta ad affermarsi quello della condivisione del sapere e dell’ampliamento degli orizzonti di ricerca nell’ambito della storia dell’arte. Che il restauro sia strumento di conoscenza, come già era implicito nell’assioma famosissimo di Brandi di “restauro coma atto critico” e di “momento di riconoscimento dell’opera d’arte”, resta spesso solo un assioma, in cui il dare e l’avere procedono per un sentiero a senso unico. Come se la storia dell’arte sola illuminasse la strada e non invece avesse bisogno a sua volta di farsi interrogare e mettere in discussione dal lavoro del restauro, nel suo divenire e nei suoi risultati, e della diagnostica artistica. Sarebbe ancora oggi necessario, e sempre di più, rovesciare la visione che sola si è affermata, del contributo della storia dell’arte al restauro e considerare invece il contributo che il restauro dà alla storia dell’arte.
Tutti gli storici dell’arte che lavorano nel campo della tutela e del restauro ben conoscono purtroppo la strisciante (ma nemmeno troppo) forma di condiscendenza paternalistica con cui il mondo accademico perseguita, cerio in ambito italiano, ma forse anche europeo, colui che si occupa della disciplina applicata. L’accademico, il teorico, si sente depositario di un tipo di sapere più puro e. complice la tradizione culturale che ha sempre visto tecnica e teoria come antitetiche, questa è la linea che ha dominato, che ha colonizzato le università e quindi la formazione a tutti i livelli, che si è imposta come centrale nei desideri delle nuove leve.
Diversa è la situazione invece in ambito anglosassone, in cui già da tempo, dagli anni Venti, ad Harvard, nasce la cosiddetta Technical Art History, ormai disciplina acclarata e assolutamente paritaria ad ambiti più teorici.
Eviterò di elencare, in maniera frettolosa e sommaria, dati gli scopi di questo breve testo e gli spazi a disposizione, tutte le esperienze negative e tutte quelle positive attraverso le quali il discorso fin qui fatto si sostanzia di fatti e si pone ancora come una sfida dei nostri tempi. Sarebbe spesso un possibile e spiacevole auotobiografismo o rischierebbe di non dare il debito riconoscimento a tutte le casistiche importanti che si sono succedute negli anni. Vorrei però citare, a puro titolo aneddotico, alcuni brani estrapolati da testi a carattere scientifico che rendono importanti testimonianze alla duplicità avversativa di cui ancora soffre il mondo degli storici dell’arte legati al campo del restauro.
Non molti decenni fa un illustre storico dell’arte, per colmo delle cose della vita dichiaratamente marxista, ebbe a definire gli storici dell’arte che lavoravano in soprintendenza, “i manovali della storia dell’arte”. E, più recentemente, cogliendo di fiore in fiore, si è dovuto leggere della “nuova ossessione per i dati tecnici” (nel 2002) e che “le documentazioni diagnostiche vengono scialate e pubblicate in maniera feticistica” (2010).
A parziale compensazione viene la posizione diametralmente opposta affermala nel 1984 da Marco Chiarini, che nell’introduzione alla mostra “Raffaello a Firenze” scrisse: “Ma l’ambizione della mostra è, e resta soprattutto, quella di fornire nuovi dati ed elementi di giudizio critico emersi dall’indagine tecnica che è stata alla base della sua organizzazione: senza i risultati offerti dai rilievi oggi resi disponibili da tecniche avanzate come quella della riflettografia e del restauro, la mostra non avrebbe quasi avuto una giustificazione”. Una straordinaria affermazione, forse ancor oggi ineguagliata, di debito nei confronti di diagnostica e restauro da parte della storia dell’arte, in una mostra storica che fu fortemente voluta quasi a dimostrazione del valore culturale di un mondo che faticosamente, invece, ancor oggi, stenta a essere riconosciuto.
Sulla stessa lunghezza d’onda si colloca l’affermazione di Orietta Rossi Pinelli, sul “Bollettino d’arte”, nel 2003, per cui la cultura del restauro si confermava “un crocevia senza eguali dì tensioni, proiezioni, interpretazioni del passato e consapevolezza del presente. […] che ha il merito dì saldare cultura materiale e cultura intellettuale”.